
|
||||||||||||||||||||||||||||
Il potere Aerospaziale
fonte sito ufficiale AM
Il Potere Aerospaziale (PA) è la funzione militare in grado di controllare e
utilizzare l’aerospazio. Il Potere Aerospaziale è un bisogno primario per
costruire sicurezza, fattore chiave per la protezione e la difesa
dell’Italia, cruciale nel fronteggiare scenari di crisi e nel perseguire gli
obiettivi posti dalla politica. Il Potere Aerospaziale è uno strumento
strategico utilizzato per le sue intrinseche caratteristiche di flessibilità
e velocità dall’autorità politica per garantire l’essenziale cornice di
sicurezza entro cui la società civile cresce e si sviluppa.
Percorrere rilevanti distanze in minuti e ore, anziché in giorni e
settimane, possedere una dimensione globale in tutti i teatri operativi,
godere di assoluta libertà di manovra al di fuori delle limitazioni imposte
dalla geografia del globo, avere la capacità di acquisire e gestire
informazioni complesse sono caratteristiche proprie del Potere Aerospaziale,
fattore chiave delle moderne operazioni militari. I pilastri del Potere
Aerospaziale sono: controllo dell’aria, capacità di colpire con precisione,
mobilità aerea, intelligence & situational awareness e infine comando e
controllo, cuore e collante del PA.
I costi elevati sono determinati dall’uso abilitante di tecnologie avanzate
necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati in maniera efficace e con
un minore rischio di perdita di vite umane. Le spese sostenute trovano
ragion d’essere nell’importanza dell’investimento di lunga durata, nel
fondamentale contributo alla sicurezza che lo strumento aerospaziale
permette e nei ritorni di know how e occupazionali a beneficio del Paese.
La storia dell’AERONAUTICA
link
alla pagina UFFICIALE
Giulio Dohuet : La teoria del potere aereo
 |
|
fonte WIKIPEDIA
Giulio Douhet, (Giulio Felice Giovanni Battista all'anagrafe[3]) nasce da
una famiglia di origini savoiarde. Il padre, ufficiale farmacista del Regio
Esercito, scelse di diventare cittadino del Regno di Sardegna dopo la
cessione del 1860 di Nizza e Savoia. Dopo l'Unità d'Italia (17 marzo 1861)
venne trasferito a Caserta, dove nacque Giulio che a vent'anni frequentò
l'Accademia Militare di Modena, da cui uscì col grado di sottotenente dei
bersaglieri. Si iscrisse anche al Politecnico di Torino, laureandosi in
ingegneria.
La sua carriera militare fu travagliata. Nel 1911, durante la guerra
italo-turca per il controllo della Libia, gli venne assegnato il compito di
scrivere un rapporto sull'uso dell'aviazione da guerra. In esso teorizzò che
l'unico uso efficace era il bombardamento da alta quota. In effetti, il
primo impiego bellico di aeroplani della storia fu condotto dagli Italiani
nel corso di quel conflitto e il primo bombardamento fu messo in pratica il
1º novembre 1911 dalla sezione aviazione del Battaglione specialisti del
Genio, che bombardò le posizioni turche di Ain Zara.
Il 27 giugno del 1912 la legge numero 698 istituiva il Servizio Aeronautico,
presso la Direzione Generale Genio ed Artiglieria e creava il Battaglione
Aviatori con reparti di aeroplani e scuole di volo presso l'Aeroporto di
Torino-Mirafiori. Douhet, promosso maggiore, divenne il comandante del
battaglione dal 13 novembre 1913 e l'organizzò in squadriglie perfettamente
autonome dal punto di vista organizzativo e logistico, dotandole di
aviorimesse smontabili, automezzi e carri officina.
Lo stesso anno promosse un'iniziativa per la raccolta di tutti i cimeli
aeronautici militari italiani che si erano ormai accumulati dal 1884, epoca
dei primi aerostieri del Genio. L'iniziativa portò alla realizzazione del
primo museo aeronautico in Italia, costituito acquisendo la sede del Museo
storico del Genio a Roma presso Castel Sant'Angelo. La collezione, dopo
molti spostamenti e vicissitudini ha costituito la base dell'attuale museo
storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
Scrisse il libro Regole per l'uso degli aeroplani in guerra, uno dei primi
manuali di dottrina sulla materia, ma le sue teorie vennero viste come
troppo radicali. Nella seconda metà del 1914, Douhet si assunse la
responsabilità di far avviare alla Caproni la costruzione del grosso
bombardiere trimotore Ca.31, malgrado il parere contrario del generale
Maurizio Mario Moris, ispettore dell'Aeronautica. Per questo atto privo di
autorizzazione venne allontanato dall'aviazione e destinato alla Fanteria,
con incarico a Edolo presso lo stato maggiore della 5ª Divisione, in quel
momento in retroguardia sul fronte dell'Adamello.
La prima guerra mondiale
Allo scoppio della prima guerra mondiale, Douhet cominciò a invocare un
massiccio investimento nella costruzione di aerei da bombardamento, per
ottenere il controllo dell'aria e privare il nemico delle difese. Propose la
costruzione di cinquecento bombardieri in grado di lanciare 125 tonnellate
di bombe al giorno. Scrisse ai superiori e ai vertici politici per
promuovere le proprie idee e criticare l'incompetenza in materia degli alti
comandi. L'atteggiamento critico riguardo alla conduzione della guerra da
parte del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Cadorna, gli
procurò l'ostilità delle alte gerarchie. Un memoriale diretto a Leonida
Bissolati, assai critico nel contenuto verso lo Stato Maggiore, venne
intercettato e ne conseguì un processo militare per diffusione di notizie
riservate. Douhet venne conseguentemente condannato a un anno di carcere
militare, che espiò nel forte di Fenestrelle.[6]
Il dopoguerra e il monumento al Milite Ignoto
Dopo la battaglia di Caporetto, che screditò il suo avversario Cadorna,
scontato il periodo di pena (che trascorse in cella a scrivere
sull'argomento che ormai lo ossessionava), tornò in servizio. Douhet venne
proposto da Armando Diaz per un incarico al commissariato generale per
l'aeronautica del Ministero delle armi e munizioni, ma lasciò di nuovo
polemicamente il servizio quando entrò in conflitto con Ferdinando Maria
Perrone, dell'Ansaldo, su questioni relative alle commesse.[7] Riuscì poi a
ottenere una revisione del processo che portò all'annullamento della
condanna subita e la promozione a generale, mentre nel frattempo continuava
a scrivere.
In precedenza, nel 1920, mentre era un colonnello in congedo, fondò l'Unione
nazionale ufficiali e soldati e, sulla scorta di analoghe iniziative già
attuate in Francia e in altri Paesi coinvolti nella "Grande Guerra", propose
di erigere monumenti ai caduti della "Grande Guerra" in ogni città d'Italia
e - primo in Italia[8] - di onorare i caduti italiani le cui salme non erano
state identificate, con la creazione di un monumento al Milite Ignoto a
Roma, presso il Vittoriano.
Il dominio dell'aria
Nel 1921 pubblicò Il dominio dell'aria, il suo libro più noto, che ebbe
molta fortuna all'estero[10]. Tale saggio fu oggetto di attento studio,
particolarmente da parte dei fautori della nascente specialità
dell'aeronautica militare come l'americano Billy Mitchell, che ebbe modo di
conoscere nel 1922 e al quale illustrò la sua opera.[11]. Le forze armate
britanniche invece non prestarono apparentemente attenzione al libro e gli
autori inglesi ritengono sia stato Hugh Trenchard, il padre della Royal Air
Force il primo teorico del bombardamento strategico, poi di fatto attuato
durante la seconda guerra mondiale, sotto le direttive di Sir Arthur Harris.
Fu promosso generale di divisione nel 1923, restando in aspettativa. È da
segnalare che le teorie di Douhet trovarono, fra le due guerre, un certo
seguito anche nell'Unione Sovietica: alla metà degli anni trenta le forze
aeree dell'URSS disponevano di circa 1000 bombardieri bimotori e
quadrimotori destinati all'attacco strategico[15]. Sempre nel 1921, grazie
anche alle sue amicizie all'interno del neonato Partito nazionale fascista,
Douhet venne richiamato in servizio e nominato maggior generale, ricevendo
l'incarico di Capo dell'Aviazione,[16] ma presto abbandonò il lavoro troppo
burocratico per dedicarsi interamente allo studio.
Douhet non conseguì mai il brevetto di pilota. Scrittore e polemista
brillante, scrisse anche due brevi opere che oggigiorno verrebbero
classificate come fantapolitica: La vittoria alata e La guerra del '19.
Nella prima si immagina un finale alternativo della prima guerra mondiale:
gli Imperi Centrali sono costretti alla capitolazione non da una sconfitta
sui fronti terrestri bensì da un'offensiva aerea strategica. Nel secondo,
collocato temporalmente negli anni trenta del XX secolo, si immagina una
guerra tra Francia e Belgio da un lato e una riarmata Germania; vince la
Germania che punta su di una forte aviazione strategica e sugli attacchi ai
centri urbani del nemico. Coerentemente con sé stesso, Douhet, anche nelle
opere di finzione, riteneva necessaria e sufficiente per il conseguimento
della vittoria una forte aviazione strategica.
La scomparsa e la tomba
Morì nel 1930 colpito da un infarto, mentre coltivava rose nel suo giardino.
È sepolto, insieme con la moglie, Teresa (Gina) Casalis, che morì nel 1960.
La tomba dove riposano assieme è a Roma al Cimitero del Verano. La vedova vi
fece scolpire la seguente iscrizione:
« Anima e cuore di soldato italiano spirito colto geniale e lungimirante fin
dai primi tentativi dell’aviazione intravide l’ineluttabile avvento delle
armate del cielo e per la patria una ne invocò strenuamente con gli scritti
e con la parola sprezzando ogni personale interesse. Di ogni ideale umano e
patriottico profondamente pervaso primo in Italia e fuori il culto del
milite ignoto propose. Doveva triste destino del genio chiudere la vita
perché le sue idee fossero attuate e fosse proclamato maestro MCMXXX – La
vedova orgogliosa »
Nel 2008 un articolo sulla rivista della Associazione arma aeronautica
denunciò lo stato di degrado della tomba. L'articolo portò al lancio di
iniziative per il restauro[19], che si completarono in occasione della
commemorazione degli 80 anni dalla morte, con una cerimonia il 19 febbraio
2010 presso il cimitero, con deposizione di una corona di alloro alla
presenza degli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet,
l'istituto di formazione militare con sede a Firenze che l'Aeronautica
Militare ha voluto intitolargli nel 2006. Il portale web dell'Aeronautica
Militare ha proposto una pagina, intitolata "I grandi aviatori", dove
vengono citate le maggiori personalità storiche dell'aviazione italiana,
ponendo Douhet tra di esse.
La dottrina sul dominio dell'aria
Secondo Douhet l'aeroplano non poteva più essere inteso solo come un mezzo
ausiliario dell'Esercito e della Marina per colpire obiettivi terrestri e
navali, bensì era diventato l'unico mezzo per combattere una terza lotta
nella nuova dimensione, l'aria. Il generale auspicava dunque parallelamente
alla permanenza delle Aviazioni dell'Esercito e della Marina, la formazione
di una "terza sorella": l'"Armata Aerea". Questa sarebbe stata la sola e
unica forza armata capace di garantire la conquista del "dominio dell'aria",
conquista necessaria per proteggere i cieli italiani dall'aggressione di
mezzi aerei nemici e unico mezzo capace di garantire il possesso dei cieli
avversari in un conflitto.
Incidentalmente si osserva che Douhet era scettico sulle possibilità di
difesa antiaerea, sia a mezzo caccia sia tramite artiglieria e,
conseguentemente, non riteneva si dovesse investire negli aeroplani da
caccia, teorizzò invece come guerra di "contraviazione" il bombardamento dei
campi da volo nemici attraverso materiale esplosivo che crei "imbuti di
scoppio".
Douhet prevedeva, sin dalle premesse della sua opera, un impiego di massicci
quantitativi di aeroplani, dispiegati in grosse formazioni. Nel suo libro
scriveva:
« Immediatamente sorge il primo principio del suo impiego: l'Armata Aerea
deve venire impiegata in massa. Questo principio è perfettamente identico a
quello che regge la guerra terrestre e quella marittima. L'effetto materiale
e morale delle offese aeree - come di qualunque altra offesa - è massimo
quando le offese stesse vengono concentrate nello spazio e nel tempo. »
Secondo i detrattori, invece, egli affermava che l'obiettivo dei
bombardamenti incendiari, chimici e batteriologici dovevano essere non tanto
le forze armate avversarie, ma soprattutto le popolazioni civili e le città
densamente popolate. Douhet nel suo trattato scrisse di bombe "velenose" il
cui effetto aveva una durata limitata e presumibilmente, come tradussero gli
americani, faceva riferimento ai gas già sperimentati durante la prima
guerra mondiale. I passi che hanno scatenato la controversia sono tra gli
altri:
« Ammettiamo, sempre in via di ipotesi, che la Germania possegga una
Armata Aerea e la Francia l'attuale aviazione militare: in questo caso, se
la Germania si decidesse ad attaccare la Francia, le converrebbe, nella
prima giornata di operazioni, distruggere 50 stabilimenti d'aviazione
francese, oppure gettare 50 superfici distruggibili su Parigi e dintorni,
per togliere alla Francia non la sua aviazione, ma il suo cervello?" »
« Basta immaginare ciò che accadrebbe, fra la popolazione civile dei
centri abitati, quando si diffondesse la notizia che i centri presi di mira
dal nemico vengono completamente distrutti, senza lasciare scampo ad alcuno.
I bersagli delle offese aeree saranno quindi, in genere, superfici di
determinate estensioni sulle quali esistano fabbricati normali, abitazioni,
stabilimenti ecc. ed una determinata popolazione. Per distruggere tali
bersagli occorre impiegare i tre tipi di bombe: esplodenti, incendiarie e
velenose, proporzionandole convenientemente. Le esplosive servono per
produrre le prime rovine, le incendiarie per determinare i focolari di
incendio, le velenose per impedire che gli incendi vengano domati dall'opera
di alcuno. L'azione venefica deve essere tale da permanere per lungo tempo,
per giornate intere, e ciò può ottenersi sia mediante la qualità dei
materiali impiegati, sia impiegando proiettili con spolette variamente
ritardate. »
(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 24)
« Immaginiamoci una grande città che, in pochi minuti, veda la sua parte
centrale, per un raggio di 250 metri all'incirca, colpita da una massa di
proiettili del peso complessivo di una ventina di tonnellate: qualche
esplosione, qualche principio d'incendio, gas venefici che uccidono ed
impediscono di avvicinarsi alla zona colpita: poi gli incendi che si
sviluppano, il veleno che permane; passano le ore, passa la notte, sempre
più divampano gli incendi, mentre il veleno filtra ed allarga la sua azione.
La vita della città è sospesa; se attraverso ad essa passa qualche grossa
arteria stradale, il passaggio è sospeso. »
(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 67)
« Ed, in ordine al conseguimento della vittoria, avrà certamente più
influenza un bombardamento aereo che costringa a sgombrare qualche città di
svariate centinaia di migliaia di abitanti che non una battaglia del tipo
delle numerosissime che si combattono durante la grande guerra senza
risultati di apprezzabile valore. »
(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 166)
Tuttavia Douhet è ben conscio della delicatezza necessaria della scelta
degli obiettivi, ne è testimone la trattazione riportata in forma di domande
rivolte al lettore
« Ammesso che un eventuale nostro nemico possegga una Armata Aerea
provvista di unità da bombardamento della superficie distruggibile di 500
metri di diametro e di un raggio di azione adeguato:
1. - Quante unità da bombardamento occorrerebbero per tagliare tutte le
comunicazioni ferroviarie del Piemonte e della Liguria col resto
dell'Italia, in un solo giorno?
2. - Quante unità da bombardamento occorrerebbero per tagliare Roma da tutte
le comunicazioni ferroviarie, telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche,
gettando Roma stessa nel terrore e nella confusione mediante la distruzione
dei principali ministeri e delle banche maggiori, in un sol giorno?" »
Le teorie di Douhet furono e tuttora sono oggetto di studio e controversia
da parte degli storici militari e degli studiosi di strategia dagli anni
venti del ventesimo secolo fino ad oggi.[6][23][24][25] Nel 1945 la
realizzazione e l'impiego bellico delle armi nucleari, cui seguì la resa
incondizionata del Giappone, sembrò confermare le teorie di Douhet[26]. Gli
studiosi hanno analizzato le principali campagne militari dalla seconda
guerra mondiale fino ai recenti avvenimenti dei Balcani, dell'Afghanistan e
dell'Iraq. Tutti riconoscono l'imprescindibilità del potere aereo, ma pochi
concordano che una campagna militare possa essere decisa solamente
dall'aeronautica.
Le teorie di Douhet vennero subito criticate in Italia, tanto da portarlo
allo scontro con l'establishment militare (anche se forse l'ostilità era più
diretta all'uomo - e ai gruppi di interesse che lo sostenevano - che non
alle teorie che egli promuoveva).[12] Nella seconda guerra mondiale la
guerra aerea ha visto gli impieghi massicci di bombardieri strategici che
lui preconizzava, ma i bombardamenti aerei a tappeto delle città inglesi e
tedesche non sono bastati a risolvere da soli il conflitto, mentre lo
spettro di una totale distruzione nucleare portò il Giappone alla resa. Né
le guerre successive al 1945 hanno confermato le teorie del Douhet.[22] La
netta superiorità aerea delle forze delle Nazioni Unite non impedì che la
guerra di Corea si trascinasse per oltre tre anni con ingenti costi umani e
materiali. Né il bombardamento strategico assicurò la vittoria agli Stati
Uniti d'America nella guerra del Vietnam.
Per contro, in altre campagne come la guerra delle Falkland, combattuta dal
Regno Unito e dall'Argentina per il possesso dell'Arcipelago delle Falkland
nell'Oceano Atlantico, si è rivelata imprescindibile e decisiva l'azione
dell'aviazione tattica.[27] Quindi le visioni apocalittiche di Douhet si
sono dimostrate nello stesso tempo corrette e no:[12] corrette nel
profetizzare una nuova forma di guerra di cui l'umanità avrebbe volentieri
fatto a meno; non corrette nel suggerire che l'uso del bombardamento aereo
sarebbe stato il metodo decisivo per vincere qualsiasi guerra del
futuro.[22]
Gabriele D' ANNUNZIO: Il poeta aviatore
Fonte ENAC
https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Biblioteca/D%27Annunzio_aviatore/index.html
La guerra del poeta-aviatore non fu quella di posizione delle trincee. Fu
una guerra spettacolare fatta di imprese rischiose e memorabili: i voli su
Trieste e Trento nel 1915 (in uno di questi raid D'Annunzio perse l'occhio
destro durante un ammaraggio); le incursioni su Pola e Cattaro (1917); la
beffa di Buccari (10-11 febbraio 1918); il volo su Vienna a capo della
squadriglia "La Serenissima" conclusosi con il lancio di volantini destinati
alla popolazione civile (9 agosto 1918). In virtù di queste imprese
D'Annunzio ottiene cinque medaglie d'argento, una d'oro, una di bronzo e la
Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia. Il volo su Vienna avrà
una risonanza mondiale legando indissolubilmente il nome di D'Annunzio
all'aviazione italiana di quegli anni. Congedato dall'esercito nel 1919, il
poeta transita nei ruoli ausiliari della Regia Aeronautica. E' promosso
Colonnello e poi Generale di Brigata.
Oltre alle imprese militari restano nella storia della letteratura italiana
le pagine che, in parziale sintonia col movimento futurista, il poeta
abruzzese dedicò alla tecnologia e alla velocità. Nel 1903 D'Annunzio
pubblica "Alcyone", il terzo libro delle "Laudi" (Laudi del cielo, del mare,
della terra e degli eroi). In quest'opera il mito di Icaro ricorre
frequentemente a simboleggiare la conquista dei cieli da parte dell'uomo e
il coronamento di un sogno millenario: vincere la forza di gravità.
Nel 1910 esce il romanzo "Forse che sì forse che no". Coerentemente con la
poetica dannunziana in questo lavoro i simboli della modernità (automobile e
aeroplano) diventano mezzi per l'espansione dell'Io. Il motore è il "cuore
di metallo" dal "tono potente e costante" al quale prestare "l'orecchio
attentissimo alla sestupla consonanza" che va musicalmente "riaccordato" per
riudire "il lavoro dei cilindri ridivenuto unisono, il palpito energico ed
esatto" (http://nuvolari.altervista.org/d'annunzio_e_la_tecnica.htm).
 |
 |
 |
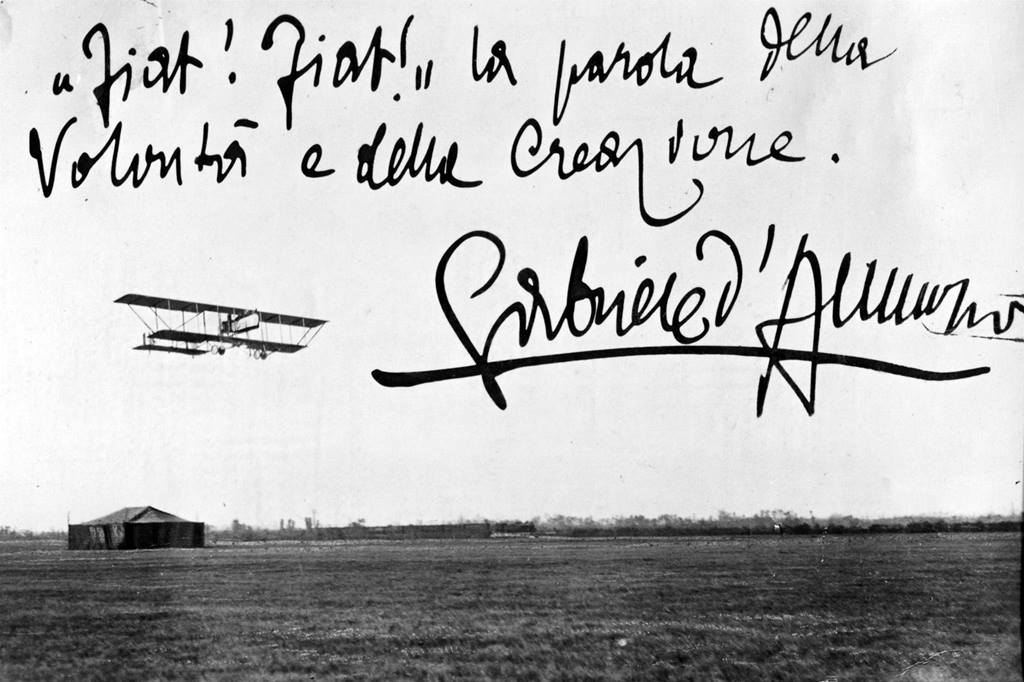 |
E' interessante notare che il termine "velivolo"
è introdotto da D'Annunzio per definire la "macchina volante" proprio nel
succitato romanzo "Forse che sì forse che no". Queste le parole del poeta:
"Ora v'è un vocabolo di aurea latinità - velivolus, velivolo - consacrato da
Ovidio, da Vergilio, registrato anche nel nostro dizionario; il quale ne
spiega così la significazione: "che va e par volare con le vele". La parola
è leggera, fluida, rapida; non imbroglia la lingua e non allega i denti; di
facile pronunzia, avendo una certa somiglianza fonica col comune veicolo,
può essere adottata dai colti e dagli incolti. Pur essendo classica, esprime
con mirabile proprietà l'essenza e il movimento del congegno novissimo.
A conferma del forte interesse di D'Annunzio per le novità introdotte dalla
moderna tecnologia presentiamo in questa sede due interventi del poeta
particolarmente significativi per la cultura aeronautica tratti
dall'Alcyone: "L'ala sul mare" e il "Ditirambo IV".
Le imprese aeronautiche e le incursioni letterarie sul volo da parte del
poeta abruzzese hanno dato luogo agli studi su D'Annunzio aviatore. Il
rapporto tra questi e il mondo aeronautico è stato oggetto di interesse da
parte di diversi storici e di molti lettori. Di tale rapporto si presenta
una selezione di opere, certamente non esaustiva, che copre un ampio arco
temporale: dal 1930 ad oggi.
Vai al percorso bibliografico e iconografico
Versi di D'Annunzio tratti dall'Alcyone:
L'ala sul mare
Ardi, un'ala sul mare è solitaria.
Ondeggia come pallido rottame.
E le sue penne, senza più legame,
sparse tremano ad ogni soffio d'aria.
Ardi, veggo la cera! E' l'ala icaria,
quella che il fabro della vacca infame
foggiò quando fu servo nel reame
del re gnòssio per l'opera nefaria.
Chi la raccoglierà? Chi con più forte
lega saprà rigiungere le penne
sparse per ritentare il folle volo?
Oh del figlio di Dedalo alta sorte!
Lungi dal medio limite si tenne
il prode, e ruinò nei gorghi solo
Ditirambo IV
Oh nel cor mio rapidità del palpito
ond'era impulso il volo, in egual numero!
Pareami già gli intaversati bàltei
esser conversi in vincoli tendínei,
tutto l'azzurro entrar per gli spiracoli
del mio pulmone, il firmamento splendere
sul mio torace come sul terribile
petto di Pan. Gridava "Icaro! Icaro!"
il mio padre lontano. "Icaro! Icaro!"
Nel vento e nella romba or sì or no
mi giungeva il suo grido, or sì or no
il mio nome nomato dal timore
giungeva alla mia gioia impetuosa.
"Icaro!" E fu più fievole il richiamo.
"Icaro!" E fu l'estrema volta. Solo
fui, solo e alato nell'immensità.
Italo BALBO : La maturità operativa
 |
II vero Papà dell' Aeronautica Militare è Italo Balbo o come lo chiamo affettuosamente io "Nonno Balbo" Il 31 ottobre 1925 infatti venne nominato sottosegretario di Stato all'aviazione. Si apprestò ad organizzare la neocostituita Regia Aeronautica come forza armata autonoma, ancora ai primi passi, coi bilanci insufficienti, bisognosa di un ammodernamento e di un aumento di prestigio. Balbo conseguì il brevetto da pilota nel 1927. Diede una sede stabile al ministero facendo costruire un nuovo palazzo con criteri architettonici 'razionalisti'. Avviò la fondazione della “città dell'aria”, Guidonia, dove sorse un modernissimo centro di ricerche d'ingegneria aeronautica, che raccolse nomi di scienziati di prim'ordine, come Gaetano Arturo Crocco, Luigi Crocco, Antonio Ferri, e Luigi Broglio, il futuro padre della ricerca spaziale italiana. Diede inoltre vita nella nuova cittadella scientifica Guidonia-Montecelio a un centro studi per coordinare e promuovere lo sviluppo aeronautico, affidandone il comando ad Alessandro Guidoni. Altra "creatura" di Balbo fu la Scuola alta velocità, nata a dicembre a Desenzano del Garda dove prima sorgeva l'idroscalo privato di Gabriele D'Annunzio; il tenente colonnello Mario Bernasconi, che ne era direttore, aveva a disposizione ogni tipo di struttura e materiali che doveva sfruttare per consegnare all'Italia l'ambita Coppa Schneider. |
Dopo il successo della crociera aerea del
Mediterraneo occidentale (25 maggio-2 giugno 1928) da lui organizzata
insieme al decisivo aiuto del trasvolatore Francesco De Pinedo, Balbo venne
fatto da Mussolini generale di squadra aerea in agosto, un simile
avanzamento di carriera, da ex capitano degli Alpini, non si era mai visto
nelle forze armate italiane, provocando il risentimento di De Pinedo, che, a
ragione, si vedeva come il vero artefice dell'impresa. In ottobre, quando
dovette essere sostituito il capo di stato maggiore della Regia Aeronautica
Armando Armani, De Pinedo venne nominato solamente sottocapo di stato
maggiore. La successiva crociera aerea del Mediterraneo orientale (5-19
giugno 1929) fu presieduta sempre da Balbo, ma De Pinedo venne incluso come
semplice pilota di uno degli aerei della formazione, in quanto la direzione
tecnica del volo andò al colonnello Pellegrini, capo del gabinetto di Balbo.
Il 20 aprile 1929 intanto fu rieletto deputato alla Camera per il PNF. Quasi
due mesi dopo, il 12 agosto, Balbo sfruttò le voci che giravano su De Pinedo
e gli chiese conto dei fondi a lui destinati per compiere il raid atlantico
del 1927. De Pinedo rispose indirizzando una lettera a Mussolini in cui
criticava le crociere spettacolari e propagandistiche che ponevano in
secondo piano la preparazione bellica (senza sapere che Mussolini era
contento di questa strategia), dando poi le dimissioni da sottocapo di stato
maggiore, che il Duce accolse con favore, reputandolo non in grado di
comprendere le esigenze del regime.
Il 12 settembre 1929, a soli trentatré anni, Italo Balbo fu nominato
ministro dell'Aeronautica, carica tenuta fino ad allora dal Duce. De Pinedo
venne allontanato con l'incarico di addetto aeronautico in Argentina[56]. In
questi anni Balbo era ricco, potente e famoso, ancora esuberante ed
entusiasta, con amicizie nel mondo della cultura e dell'industria che lo
avevano affermato tra l'alta borghesia e la nobiltà romana. Balbo guidò poi
due crociere aeree transatlantiche in formazione, inframezzati, nel 1932, da
una proposta avanzata a Mussolini circa l'istituzione di un unico ministero
per la difesa, sostenuto dalla quadruplicazione delle somme destinate alla
marina e all'aeronautica. Alla guida del nuovo ministero sarebbe dovuto
andare lo stesso Balbo ma, benché alcuni capi militari vedessero di buon
gusto l'iniziativa, le rivalità tra le forze armate e, soprattutto, la
gelosia del Duce nei confronti della popolarità del ministro aviatore,
fecero naufragare l'intero progetto.
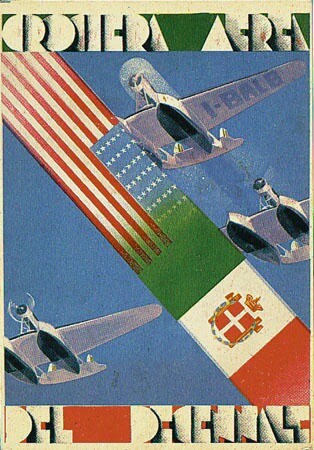 |
 |
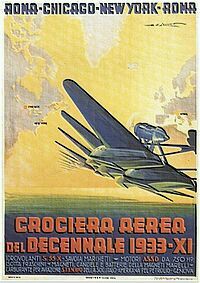 |
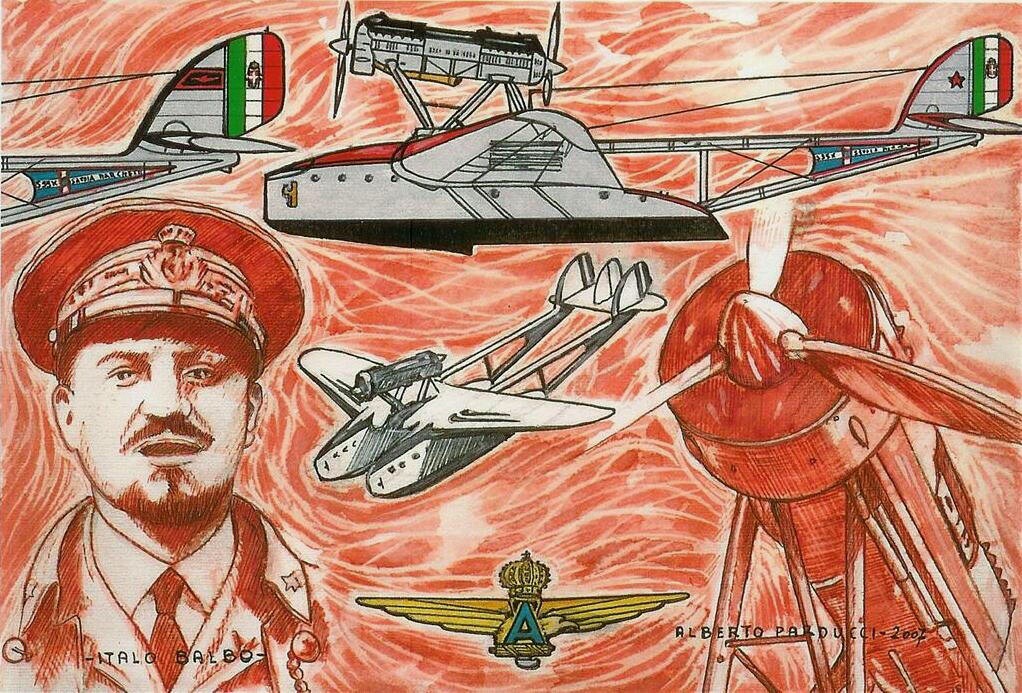 |
La prima idea per una crociera aerea
oltreoceano gli venne in mente durante un congresso internazionale
aeronautico negli Stati Uniti, dove si convinse che il primo gruppo di aerei
che avesse attraversato in formazione l'oceano Atlantico sarebbe passato
alla storia. Nel 1929 persuase l'ingegnere Alessandro Marchetti a mettere a
punto per l'impresa gli idrovolanti S.55A che sarebbero andati ad
equipaggiare uno stormo creato ad hoc a Orbetello. Si scelse di trasvolare
l'Atlantico meridionale con dodici apparecchi, a cui la Regia Marina avrebbe
fornito appoggio con cinque cacciatorpediniere.
Gli idrovolanti partirono infine per la crociera aerea transatlantica
Italia-Brasile da Orbetello il 17 dicembre 1930, guidati personalmente da
Balbo e dal suo secondo pilota Stefano Cagna, alla volta di Rio de Janeiro,
dove arrivarono, non senza lutti e incidenti, il 15 gennaio 1931. La seconda
crociera atlantica, la crociera aerea del Decennale, venne organizzata per
celebrare il decennale della Regia Aeronautica in occasione della Century of
Progress, esposizione universale che si tenne a Chicago tra il 1933 ed il
1934. Dal 1º luglio al 12 agosto del 1933 Balbo guidò la trasvolata di
venticinque idrovolanti S.55X partiti da Orbetello verso il Canada e
con destinazione finale gli Stati Uniti. In precedenza, il 26 giugno, Balbo
era apparso nella copertina della rivista TIME.
La traversata di andata approdò in Islanda, proseguendo poi verso le coste
del Labrador. Il governatore dell'Illinois, il sindaco e la città di Chicago
riservarono ai trasvolatori un'accoglienza trionfale ed a Balbo venne
intitolata una strada, tutt'oggi esistente, in prossimità del lago Michigan,
la Balbo Avenue (ex 7th Avenue). I Sioux presenti all'Esposizione di Chicago
lo nominarono capo indiano con il nome di "Capo Aquila Volante". In
quell'epoca infatti i rapporti fra Italia e USA erano ottimi e quest'impresa
fu molto seguita e considerata straordinaria. Il volo di ritorno proseguì
per New York, dove venne organizzata in suo onore e degli altri equipaggi
una grande ticker-tape parade, secondo italiano dopo Armando Diaz ad essere
acclamato per le strade di New York, ed intitolato a Balbo uno dei suoi
viali. Il presidente Roosevelt lo ebbe ospite. Di ritorno in Italia, il 13
agosto 1933 venne promosso maresciallo dell'aria. Dopo questo episodio il
termine "Balbo" divenne di uso comune per descrivere una qualsiasi numerosa
formazione di aeroplani. Meno noto è che negli Stati Uniti il termine
"balbo" sia utilizzato anche per indicare il pizzo lungo con baffi.
 |
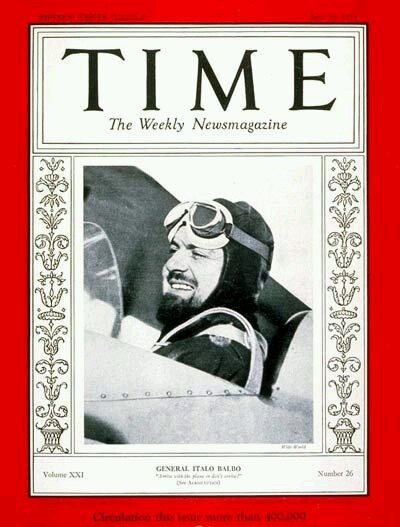 |
 |
 |
Al di là di queste imprese, Balbo dispiegò grande energia nell'imporre
disciplina e rigore alla Regia Aeronautica sin da quando ne era segretario,
accantonando gli aspetti romantici ed individualistici dell'aviazione
pionieristica ed indirizzandola piuttosto a formare una forza armata coesa e
disciplinata. I voli transoceanici in formazione furono un esempio di tale
indirizzo: non più imprese individuali, ma di gruppo e minuziosamente
programmate e studiate. Così facendo però diede troppo peso agli eventi
spettacolari, inducendo l'aviazione a dare troppa attenzione ai primati
sportivi, senza ricadute positive sugli aerei usati per il normale servizio.
Il prestigio accumulato dall'aviazione durante il ministero di Balbo,
comunque, diede alle autorità italiane l'impressione di avere una forza
aerea di prim'ordine. È da rilevare che se Balbo avallò le idee di Giulio
Douhet sull'aviazione strategica, nel contempo sostenne fattivamente la
costituzione dello Stormo d'assalto sotto il comando di Amedeo Mecozzi,
incoraggiando lo sviluppo dell'aviazione tattica.
Balbo si avvalse di queste due linee di pensiero per raggiungere «l'unità
organica della difesa dell'aria, e la necessità che sia esclusivamente
affidata all'armata aerea, nella quale viene riunito tutto il complesso
delle forze [...] disponibili», senza tuttavia dare all'aeronautica «una
vera e propria dottrina di guerra fissata in canoni rigidi e immutabili»
che, comunque, non era in grado di imporrei ai capi dell'esercito e della
marina, nonché agli industriali desiderosi di aggiudicarsi il più alto
numero di commesse per allargare il già eterogeneo parco velivoli. È proprio
per questo attaccamento alla guerra aerea indipendente che Balbo non affidò
mai alcun incarico a Douhet e trasferì, nel 1937, il neo-promosso generale
Mecozzi nella lontana Somalia. Si oppose alla concessione di bombardieri
alla Regia Marina e alla realizzazione di navi portaerei, che riteneva
avrebbero sottratto fondi e materiale alla Regia Aeronautica riducendo anche
l'indipendenza della neonata arma aerea. La mancata realizzazione di
portaerei influì negativamente sulle operazioni della Regia Marina nel
secondo conflitto mondiale (vedasi battaglia di Capo Matapan), ma sarebbe un
errore attribuirne la responsabilità alla sola opposizione di Balbo, vista
la posizione conservatrice dei vertici della Regia Marina.
Corradino D?ASCANIO il papà dell' elicottero
fonte WIKIPEDIA
Nasce a Popoli, comune allora della provincia dell'Aquila, oggi di Pescara
in Abruzzo, da Giacomo e Anna De Michele. La sua passione per l'allora
primordiale scienza aeronautica fu precoce. Nel 1906, a soli tre anni dal
primo volo dei fratelli Wright, dopo aver studiato le tecniche di volo e le
proporzioni tra peso e apertura alare di alcuni volatili progettò e costruì
una sorta di deltaplano, che usò per lanci sperimentali effettuati dalle
colline di Popoli.
Gli studi
Frequentò il Regio Istituto Tecnico Ferdinando Galiani di Chieti diplomatosi
nel 1909 e volendo intraprendere studi ingegneristici si trasferì a Torino
iscrivendosi al Regio Istituto Superiore d'Ingegneria che all'epoca
rappresentava il massimo nel campo dell'ingegneria meccanica. Si laurea nel
1914 in ingegneria industriale meccanica al Politecnico di Torino.
Gli anni della Grande Guerra
Nel dicembre 1914 si arruolò volontario nell'Arma del Genio nella divisione
"Battaglione Aviatori" della città di Torino dove venne assegnato al
collaudo dei motori. Nominato, in seguito, sottotenente di complemento del
Genio, il 21 marzo 1915 si occupò della prima installazione di una stazione
radio a bordo di un veicolo. In seguito fu inviato in Francia per scegliere
un motore rotativo da produrre in Italia; iniziò così la produzione dei
motori "Le Rhone".
Allo scoppio della Prima guerra mondiale D'Ascanio seguì un breve corso di
pilotaggio per Maurice Farman MF 1914, conclusosi senza il conseguimento del
brevetto a causa dei molteplici impegni che lo assorbivano in quel periodo.
In seguito venne destinato al fronte per occuparsi della manutenzione e
sorveglianza del materiale assegnato alle squadriglie di volo, modificò
circa 40 biplani Caudron che con il freddo venivano bloccati a terra dal
congelamento dell'olio lubrificante. Nel 1916 fu congedato temporaneamente e
assegnato all'Ufficio Tecnico della Società per costruzioni aeronautiche
Pomilio (in quegli anni impegnata nella fabbricazione degli apparecchi
S.P.2, Tipo C, Tipo D e altri).
 |
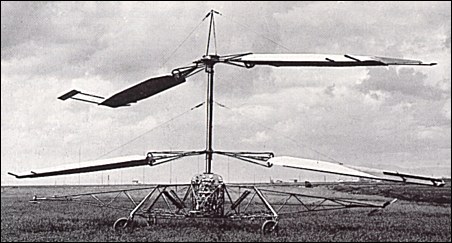 |
 |
 |
Nel 1917 Corradino si fidanzò a Popoli con Paola Paolini, nipote del
Generale Giuseppe Paolini. Anche in quell'occasione dimostrò la sua grande
inventiva: volendo comunicare con la sua fidanzata, durante i brevi periodi
di licenza a Popoli, installò due telefoni a batteria, uno in casa sua e uno
in casa di Paolina, e li collegò alla rete elettrica comunale di
illuminazione che allora erogava tensione nelle sole ore notturne. Corradino
e Paolina si sposarono il 20 ottobre 1917: dalla loro unione nacquero
Giacomo nel 1922 e Giorgio nel 1927.
L'esperienza Americana
Nel gennaio 1918 si trasferì, al servizio della neonata "Pomilio Brothers
Corporation", a Indianapolis negli Stati Uniti. Ben presto i rapporti con la
società s'incrinarono ma D'Ascanio non si scoraggiò e percorse altre strade
nel campo dell'industria aeronautica statunitense e costituì una società
aeronautica con l'ing. Ugo Veniero D'Annunzio, figlio di Gabriele
D'Annunzio, per la realizzazione di un aeroplano equipaggiato con un motore
di motocicletta Harley Davidson. Purtroppo l'avventura americana non ebbe i
risultati sperati e nel settembre 1919 Corradino D'Ascanio, deluso, ritorna
in Italia.
Al suo rientro insediò uno studio tecnico a Popoli, dove ebbe un'intensa
attività di progettazione per l'industria privata e nel settore delle opere
pubbliche. Si occupò di vari progetti di ingegneria civile, come ad esempio
la sistemazione della Piazza Giuseppe Paolini con il monumento ai caduti o,
dietro invito del pretore di Popoli, della perizia sul tronco di linea
elettrica nei pressi del bosco del Castello di Popoli "dichiarando se tale
tronco è fatto secondo le norme dettate dalla scienza e dalla pratica". Gli
anni popolesi sono anni fecondi, sono decine i brevetti degli anni venti tra
i quali troviamo il "forno elettrico a media capacità termica per cottura di
pane e per pasticceria" o la "macchina elettropneumatica per la
catalogazione e ricerca rapida di documenti", una macchina che utilizza
delle schede perforate per l'azionamento di circuiti elettrici.
L'Elicottero
Sebbene lo studio popolese gli rendesse bene, l'idea del volo non lo
abbandonò mai e anche da Popoli mantenne un legame con il mondo
dell'aviazione. Continuò sempre gli studi ed esperimenti legati al mondo del
volo, e nel biennio 1923-24 è documentata ad esempio una spesa di 266.510
lire per lo studio di un ortottero. Nel 1925 fondò una Società con il barone
Pietro Trojani di Pescosansonesco, che credette subito nel progetto
dell'elicottero e mise a disposizione il suo patrimonio, con lo scopo di "di
far sorgere e prosperare un'industria aviatoria in questa industriosa zona
d'Abruzzo". Tra il 1925 e il 1930 sono numerosi i brevetti della nuova
società relativi al mondo aeronautico e non solo.
Nel 1925 viene avviata la costruzione e l'assemblaggio dei pezzi meccanici
che compongono l'elicottero. In base ad un accordo con Eugenio Camplone i
pezzi sono prodotti presso le omonime officine di Pescara, in cambio
D'Ascanio progetta per le Officine Camplone macchine industriali e agricole
come torchi per frantoi. Nascono nel cortile delle officine Camplone a
Pescara i prototipi dell'elicottero D'AT1 e D'AT2, entrambi volano per pochi
secondi e poi ricadono a terra. I prototipi consentiranno a D'Ascanio di
progettare un nuovo elicottero, molto superiore ai precedenti.
Il D'AT3
Il terzo prototipo, il D'AT3 (la sigla sta per D'Ascanio-Trojani-3),
commissionato dal Ministero dell'Aeronautica per un importo di 600.000 lire
fu realizzato nelle officine del Genio Aeronautico a Roma. Le prove di volo
vengono effettuate nell'aeroporto militare di Ciampino Nord, il pilota
collaudatore è il maggiore Marinello Nelli (primo in assoluto a sperimentare
il volo verticale). Nell'ottobre del 1930 il D'AT3, con un motore Fiat A.50
S HP90 conquista i primati internazionali di:
durata del volo con ritorno senza scalo 8'45" (8 ottobre 1930)
distanza in linea retta senza scalo m 1078,60 (10 ottobre 1930)
altezza sul punto di partenza m 18 (13 ottobre 1930)
I primati di volo stabiliti da questo primo elicottero moderno rimarranno
imbattuti per alcuni anni. La Domenica del Corriere dedicò all'evento la sua
copertina, mentre tutti i quotidiani riportarono la notizia in caratteri
cubitali. L'elicottero venne brevettato in quasi tutti i paesi occidentali e
in Giappone ma nonostante l'interesse della Regia Marina e l'incoraggiamento
verbale del capo del governo, Benito Mussolini, i finanziamenti non vengono
rinnovati e il D'AT3 venne abbandonato nell'hangar dirigibili di Ciampino.
La realizzazione dell'elicottero esaurì i capitali messi a disposizione dal
barone Trojani mentre tramontarono una dopo l'altra tutte le prospettive di
perfezionamento del prototipo e del suo sfruttamento commerciale.
Vittorioso con il suo elicottero prototipo ma senza prospettive commerciali,
D'Ascanio nel 1931 si trovava in una condizione di quasi povertà. La
dedizione al volo verticale fu pagata a caro prezzo.
L'elica a passo variabile
D'Ascanio, grazie al suo elicottero, divenne il massimo esperto italiano di
eliche a passo variabile in volo. A quel tempo anche l'industria aeronautica
iniziava ad averne bisogno per le crescenti prestazioni degli aerei. Fu
grazie alle competenze maturate con il D'AT3 che su D'Ascanio si
concentrarono le attenzioni della sezione aeronautica della Società Rinaldo
Piaggio.
Nel 1932 D'Ascanio cominciò un'attività di consulenza tecnica con la
Piaggio. L'elica salvò appena in tempo il giovane ingegnere dal disastro
economico, aveva contratto numerosi debiti e aveva dovuto attingere anche
alla dote della moglie. L'elica a passo variabile ben presto lo portò dal
baratro alla agiatezza economica: D'Ascanio infatti percepiva mille lire per
ogni pezzo realizzato. La richiesta di eliche incrementò ben presto negli
anni pre-bellici e bellici. Le eliche Piaggio-D'Ascanio vennero in pochi
mesi montate sui migliori aerei italiani, Macchi e Caproni. Dietro il record
mondiale di altezza del colonnello Mario Pezzi, che raggiunse i 17.000
metri, e il suo biplano Caproni Ca.161bis dotato di motore Piaggio P.XI
RC.100/2v c'erano le eliche D'Ascanio, che in quell'occasione introdusse
anche il respiratore con ossigeno liquido per il pilota.
L'elicottero PD3
Gli anni precedenti la seconda guerra mondiale consentirono a D'Ascanio di
lavorare con una certa tranquillità economica nell'ambiente giusto per la
sua creatività nel campo dell'aviazione. La sua passione è tutta per
l'elicottero ma in Piaggio all'inizio l'interesse per questa macchina è
praticamente nullo. Nel 1935 viene progettato un nuovo elicottero per il
Ministero dell'Aeronautica: il PD2 (Piaggio-D'Ascanio2), del prototipo PD1
che aveva ancora i rotori coassiali non si hanno molte notizie. Nel 1937 il
PD2 non era ancora pronto, tramontò così la scommessa dell'Aeronautica. Nel
1939 progetta e realizza il PD3 che ha un solo rotore e l'elica di contro
coppia in una configurazione che rispetta quella dei moderni elicotteri.
Sebbene questo approccio non fosse inedito, non era ancora stato studiato
nei dettagli. D'Ascanio non ebbe però la fortuna di Igor Sikorsky che riuscì
a convincere la United Aircraft a sviluppare i suoi progetti. Lo sviluppo
del PD3 andava a rilento, era scoppiata la guerra e non c'era interesse
nell'invenzione da parte dell'Aeronautica. Il PD3 rimase così a terra fino
al 1942 quando fu provato in volo e subito dopo ricoverato in un capannone a
Buti.
L'elicottero PD4
Nell'aprile del 1948 D'Ascanio riceve l'invito a partecipare al IV congresso
per l'elicottero organizzata dalla American Helicopter Society. Fu accolto
come il pioniere del volo verticale e il suo entusiasmo per l'elicottero
riprese. Al suo ritorno in Italia riuscì a convincere Enrico Piaggio a
riprendere gli studi. Nel 1949 rinacque il PD3 recuperando tutto ciò che era
possibile dalla prima versione, il PD3 volò fino al febbraio 1951 quando un
incidente mise fine alla storia di questo sfortunato prototipo. L'incidente
non raffreddò l'entusiasmo di D'Ascanio e nemmeno quello di Enrico Piaggio
che chiese la realizzazione di un elicottero con due rotori in tandem. Nel
1951 inizia il progetto del PD4.
Sin dalle prime prove si evidenziò che la potenza installata era
insufficiente, di conseguenza la governabilità ne veniva a soffrire.
L'elicottero fu alleggerito rimuovendo la carenatura e gli esperimenti
continuarono fino al 5 agosto 1952 quando fu sfiorata la tragedia,
fortunatamente non ci furono perdite umane ma l'incidente segnò la fine del
PD4. La bontà del progetto era evidente ma era anche evidente che andavano
eseguiti altri tentativi e investimenti. Enrico Piaggio non era disposto a
sostenere ulteriori investimenti, tutti gli sforzi dell'azienda di Pontedera
erano rivolti alla Vespa, lanciatissima in tutta Europa.
L'ultimo elicottero D'Ascanio
D'Ascanio rimase in Piaggio fino al 1961 anno del suo pensionamento, restò
consulente dell'azienda per ciò che riguarda la Vespa. Ufficialmente non
farà più elicotteri in Piaggio ma nel garage della sua abitazione (a volte
usufruendo delle officine Piaggio) porta avanti la costruzione di un
minuscolo elicottero per uso agricolo, per l'irrigazione dei campi,
economico e alla portata di tutti: la Vespa dell'aria. Questo elicottero fu
pronto il 20 luglio 1970, aveva soluzioni innovative come le pale in
vetroresina ma anche questo piccolo gioiello dell'inventore abruzzese ma non
trovò committenti e volò nel solo giardino di casa D'Ascanio.
La rinascita del D'AT3
Nel 1975 l'Aeronautica militare sollecitata dal generale Domenico Ludovico
procedé alla costruzione della replica a grandezza naturale del D'AT3 presso
l'aeroporto di Pisa in base ai disegni originali e sotto la direzione dello
stesso ing. D'Ascanio. A questo elicottero del 1930 l'ingegnere rimase
attaccato come ad un figlio; lo cercò inutilmente nell'immediato dopoguerra
tra i relitti e le macerie dell'aeroporto di Guidonia. Il nuovo D'AT3 è
conservato insieme al piccolo elicottero ad uso agricolo nel Museo storico
dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
La Vespa
Nel 1945 la seconda guerra mondiale è finita e ha colpito duro. L'Italia è
in ginocchio, la maggior parte delle fabbriche è distrutta.
Anche la Piaggio è alle prese con i problemi del dopoguerra, c'era da
risolvere il problema della riconversione degli stabilimenti ad una
produzione di pace. Enrico Piaggio ebbe la geniale intuizione: costruire un
motociclo, a basso costo, in pratica accessibile a tutti. Affidò
inizialmente il compito della progettazione all'ingegner Renzo Spolti che
realizzò l'MP5 soprannominato Piaggio Paperino. L'MP5 non piacque a Piaggio
e nell'estate del 1945 chiamò D'Ascanio che affrontò il problema con una
mentalità del tutto nuova.
D'Ascanio non amava le motociclette, non se n'era mai occupato dal punto di
vista costruttivo e come veicolo non gli piaceva. Pensò a un mezzo per chi
non era mai salito su una motocicletta e odiava la sua guida difficile: ideò
così la Vespa.
Il primo modello del leggendario motociclo, la 98, fa la sua comparsa
ufficiale nel 1946 quando viene esposto al salone del ciclo e motociclo di
Milano e fu subito un successo. Insieme alla Lambretta, che nacque l'anno
dopo, cambiarono lo stile di vita degli italiani.Nei 50 anni della sua
storia la Vespa diverrà lo scooter più famoso al mondo con 16 milioni di
esemplari prodotti in 130 modelli diversi al 2005.
Gli ultimi anni
Nel 1964 sottoscrive un contratto di consulenza con la società Agusta che
porterà alla progettazione di un eliante per addestramento dei piloti di
elicotteri con l'intento di spendere molto meno di quello che costava
l'addestramento su un vero elicottero. Il progetto non arrivò mai alla fase
realizzativa.
D'Ascanio muore a Pisa il 5 agosto 1981, viene sepolto a Popoli nel cimitero
comunale nella tomba di famiglia, che lui stesso disegnò, al fianco della
moglie Paola morta prematuramente. D'Ascanio ebbe un grande rammarico: è
passato alla storia come l'ideatore della Vespa, ma pochi ricordano che è
stato anche un pioniere degli elicotteri. Attualmente a suo nome è
intitolato un liceo scientifico, a Montesilvano (PE) e tutta la scuola ha
celebrato la figura di D'Ascanio con numerose mostre e rappresentazioni.
Popoli gli ha dedicato una strada e un museo dove è presente una mostra
permanente sulla sua figura e Pisa il piazzale antistante l'aerostazione
Galileo Galilei.
